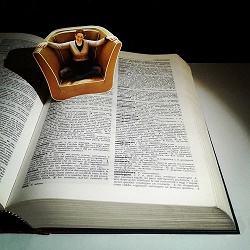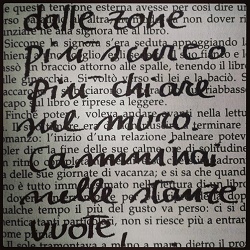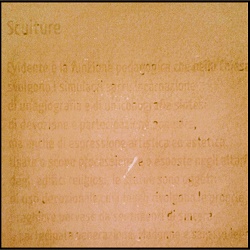|
|
|
Smercio © Simona Guerra |
Esercizi di Fotografia Consapevole #5
Quando
valgono le nostre fotografie? Chiedercelo è normale; rispondere è più
complesso soprattutto perché il termine valore ha molti significati e
il primo che gli viene dato, di solito, è quello economico.
Forse potremmo iniziare con il precisare la domanda; correggerla un po’ in modo da capire cosa intendiamo.
Potremmo ad esempio volerci domandare che valore ha da un punto di
vista di soddisfazione e gratificazione intima il gesto creativo che
abbiamo compiuto. Oppure potremmo domandarci che valore ha da un punto
di vista comunicativo, attinente al far sapere e al dire agli altri.
Forse ci interessa il suo valore sociale, o didattico, o quello
relativo al quadro contemporaneo generale. Assieme a queste,
ovviamente, una domanda potrebbe riguardare anche il valore
commerciale.
Insomma: il punto di vista da cui guardiamo le cose fa anche qui la
differenza e il “Se lo mettessi in vendita quanto vale” è solo una
delle possibilità.
Riguardo al valore intimo, più personale delle nostre opere, ho
l’impressione che il pensiero occidentale, che fa tutto con la logica
del denaro, sia così tanto inquinato che quando rispondiamo a questa
domanda teniamo comunque e sempre un po’ conto di quanto vale, tradotto
in soldi, la nostra arte.
Ma se il valore intimo, di soddisfazione e gratificazione del fare è
condizionato dal pensiero che la nostra opera potrebbe avere pochi o
nessun acquirente se fosse messa sul mercato, è fuorviante. Avvilente.
Vivere male il pensiero che all’infuori che per me quel che faccio non
vale niente può far diventare quasi doloroso il creare, fotografare,
scrivere.
Per questo il concetto di necessità è così centrale nell’arte; perché
esula da agenti esterni, perché non si cura del giudizio altrui e
produce a prescindere da qualsiasi cosa.
La domanda più importante per una Fotografia Consapevole è che valore ha quel che faccio in termini d’urgenza.
Perché in tal caso se non c’è molta urgenza, non c’è nemmeno molto valore.